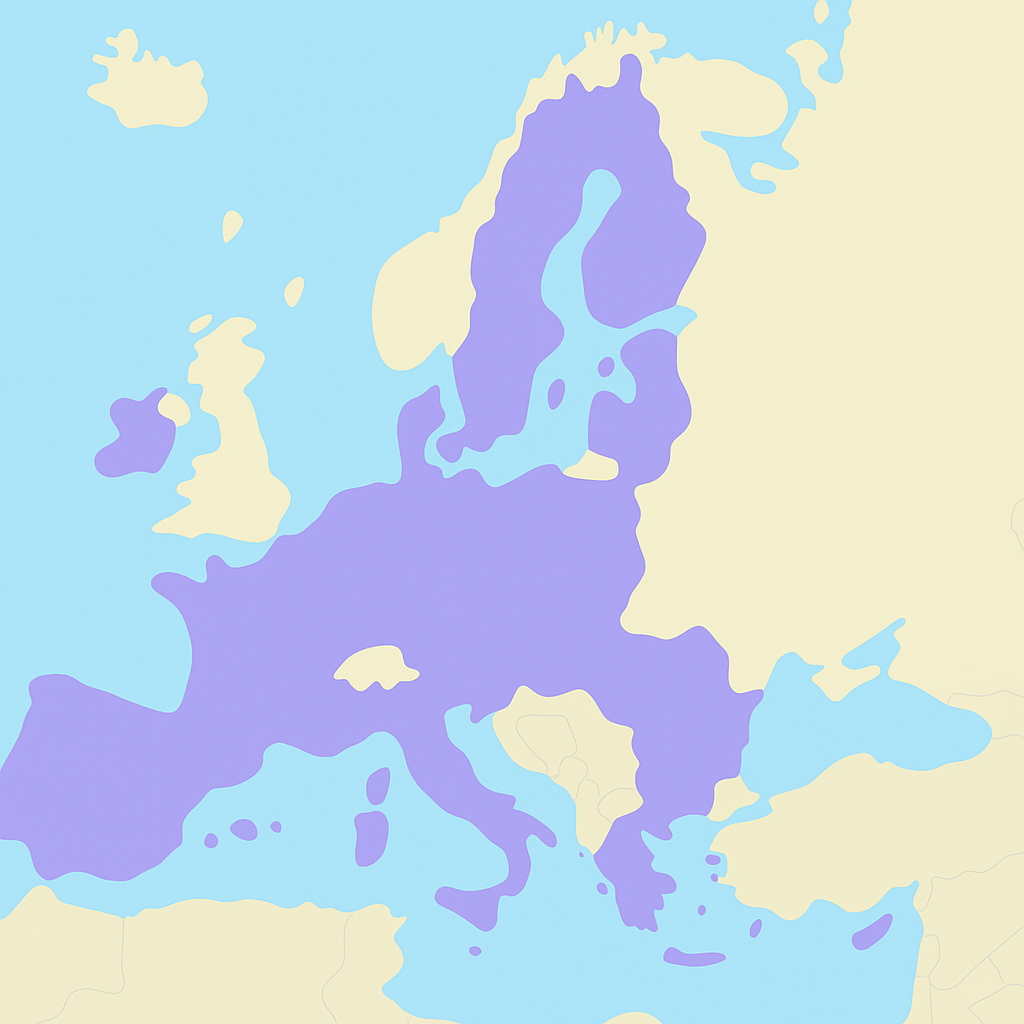
Così può correre la macchina europea
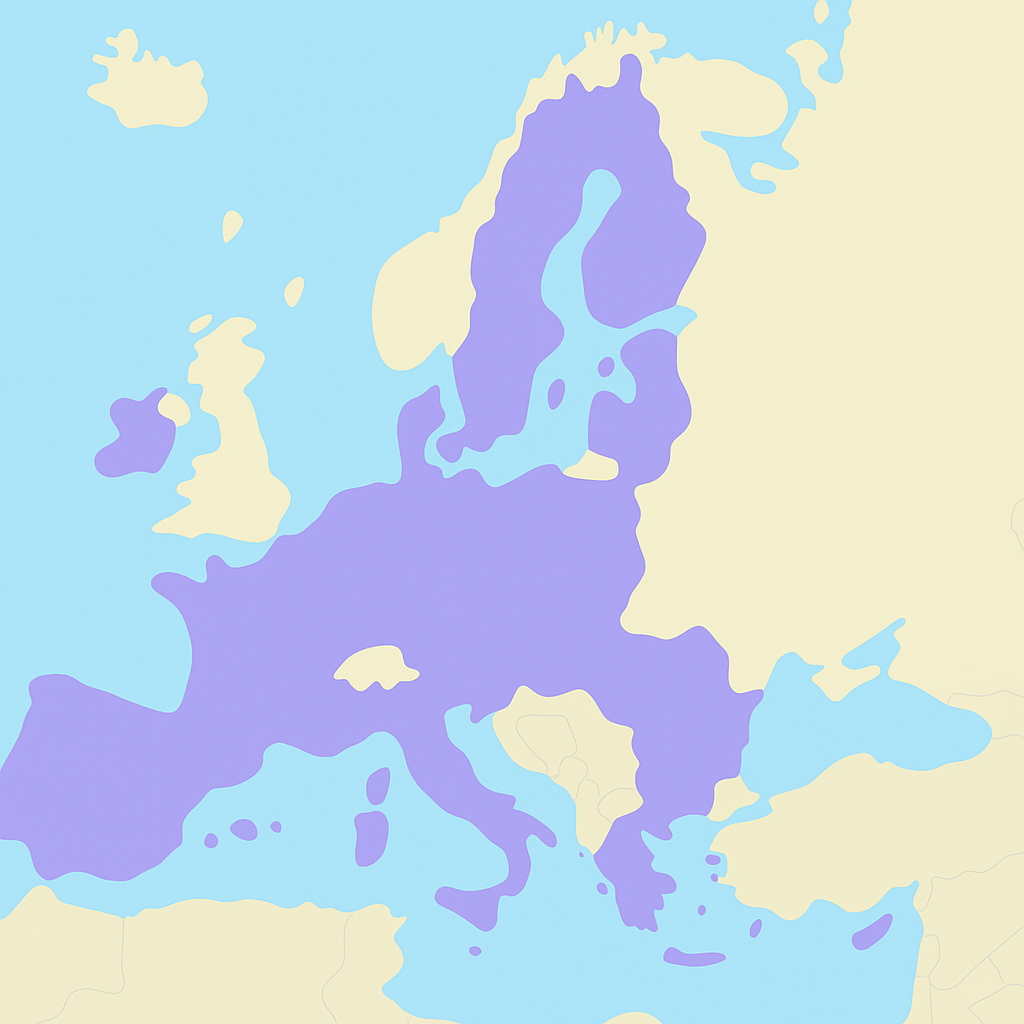
30 Settembre 2025
di Ilaria Rizzo
Senza una solida base industriale nelle tecnologie emergenti, senza autonomia nella difesa aerea e marittima, senza competenze digitali e progressi nell’intelligenza artificiale, la sovranità europea rischia di restare un’illusione. Così si propone un debito comune orientato a missioni condivise, un’alleanza più forte tra gli Stati, una semplificazione delle regole dove sembrano più soffocanti – per trasformare l’Unione da “macchina procedurale” a motore di progetti concreti.
Le priorità sono almeno tre: difesa, energia e digitale. Non capricci momentanei, ma pilastri destinati a reggere il futuro. Tuttavia, accanto a questa architettura si profila un rischio: la fiducia eccessiva nell’intervento pubblico. Se l’Unione si sostituisce al mercato, rischia di stabilire in anticipo chi vincerà e chi perderà, riducendo lo spazio della competizione. Una governance comune non bilanciata può trasformarsi in un’altra burocrazia, lenta e costosa. E gli aiuti di Stato, se usati senza misura, possono penalizzare le imprese più piccole e innescare una corsa ai sussidi fra Paesi, mettendo in pericolo proprio quel mercato unico che si intende proteggere. Per questo servono regole semplici che incoraggino l’iniziativa privata invece di soffocarla.
Ogni euro pubblico dovrebbe attrarne almeno il doppio di capitale privato, altrimenti il progetto va interrotto. Ed è più utile il “procurement”, che assegna risorse a ciò che funziona, piuttosto che i sussidi indiscriminati basati sulle promesse. Mentre i fondi comuni devono restare aperti alla competizione, la parola chiave secondo Draghi. Chi non raggiunge i risultati esce senza eccezioni. E ancora, le nuove infrastrutture digitali devono garantire accesso neutrale, per evitare la formazione di oligopoli; le deroghe alla concorrenza devono avere una scadenza precisa e non diventare permanenti.
Un progetto europeo è valido se dimostra che non sarebbe nato senza sostegno pubblico, se può crescere su scala continentale o globale e se non esclude tecnologie equivalenti, mantenendo neutralità. Deve produrre effetti concreti in tempi rapidi, basarsi su standard condivisi e distribuire opportunità anche alle aree periferiche, non solo ai grandi centri.
Alcuni ambiti richiedono ancora maggiore attenzione: l’unione dei mercati dei capitali, indispensabile per finanziare i progetti; politiche di attrazione dei talenti, senza le quali l’innovazione resta incompiuta; “sandbox” regolatorie che permettano di sperimentare prima di fissare nuove regole; standard comuni, perché chi stabilisce le regole tecniche influenza il futuro più di chi distribuisce fondi. L’Europa deve mantenere una macchina snella: poche missioni chiare, indicatori trasparenti, verifiche rapide, pagamenti legati ai risultati e revisioni periodiche per non restare vincolati a tecnologie superate.
Per l’Italia esistono opportunità di leadership: nella difesa e nel settore cyber le nostre industrie hanno competenze riconosciute, nell’energia e nell’acciaio decarbonizzato Taranto può tornare simbolo di modernità. Nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, sanità e giustizia aspettano piattaforme efficienti. Ma la vera sfida riguarda le competenze: ingegneri, data steward, artigiani digitali capaci di portare l’intelligenza artificiale nelle scuole, nei tribunali e nei territori più fragili, che possono diventare laboratori di innovazione.
La direzione indicata nelle settimane scorse da Draghi è necessaria e inevitabile. Ma ricordiamoci che la sovranità non si costruisce solo con più risorse pubbliche: occorre trasformare gli strumenti comuni in piattaforme in grado di attrarre capitali, talenti e libertà d’impresa. Solo così l’Europa potrà essere federale dove serve e competitiva dove conviene.







