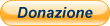Se parcheggiare i giovani è il vero disagio della società post moderna

16 Settembre 2019
Il filosofo e psicanalista U. Galimberti ritiene che «tra i quindici e i venticinque anni, quando massima è la forza biologica, emotiva e intellettuale, molti giovani vivono parcheggiati in quella terra di nessuno dove la famiglia non svolge più alcuna funzione e la società alcun richiamo, dove il tempo è vuoto, l’identità non trova alcun riscontro, il senso di sé si smarrisce, l’autostima deperisce» (Id., “I vizi capitali e i nuovi vizi”). Il mondo adulto ha sempre molto da fare per mandare avanti questa macchina di produttività nella quale siamo inseriti ormai da quando il capitalismo ha scalzato il mondo rurale. Lungi da me l’idea di un ritorno al passato! Certamente però va detto che, se è vero che il divario giovani-adulti esiste da sempre, oggi assume una dimensione ambigua: da una parte la rigida barriera generazionale che divideva la fase di passaggio all’interno della società che conta si è sgretolata, dall’altra è emerso un inedito mondo parallelo giovanile – appunto quella “terra di nessuno” fatto di movida, musica, moda, tecnologia, fantascienza, videogiochi, serie tv, social … – che l’adulto fatica a comprendere. Analizzarne le cause in un articolo come questo è pressoché impossibile se non per brevissimi e non esaustivi accenni, il rischio più grosso che bisogna evitare è quello di scadere in considerazioni moralistiche che servono solo ad alzare muri.
Il parere di M. Recalcati poggia sull’idea che, una volta superato il modello autoritario del Padre-Padrone con la contestazione degli anni ‘60/’70 (degenerando però verso un Anti-Edipo dove “tutto è possibile”, in “un’orgia dissipativa” di denaro e godimento che non fa che alimentare “il meccanismo impazzito del discorso del capitalista”), si sia approdati ad una società narcisistica che si fonda in un soggettivismo esasperato e in un consumismo sfrenato e dove non ha più ragione di esistere il limite della Legge dell’Altro. Si è arrivati al punto in cui è «permesso fare tutto da soli senza passare dalla mediazione simbolica dell’Altro grazie ai progressi della scienza medica», ma il vero problema è che in questa voracità consumistica si è depotenziato il Desiderio inteso come capacità di ad-tendere, progettare, sognare altrimenti, sperare. Paradossalmente proprio oggi dove ognuno si sente libero e creativo a modo suo, la vera creatività (intesa come costruzione di qualcosa di nuovo) è castrata, mentre questo finto “creativismo” dandy è tollerato fintanto che rimane ingabbiato nel proprio solipsismo.
Marco Aime, invece, mette in luce la quasi scomparsa, o comunque, l’attenuazione di quei tipici “riti di iniziazione” che hanno caratterizzato la nostra cultura fino a poche decine di anni fa, dove il loro significato simbolico dava forza e valore al discorso comunitario (ad esempio il matrimonio e, prima, il fidanzamento ufficiale). Molti di questi riti resistono ma in modo blando e altri hanno snaturato il loro modello “arcaico”. Sempre dopo il periodo della contestazione, che vide un ribaltamento epocale degli equilibri sociali, le generazioni dei successivi anni ‘80/’90 si trovarono a vivere un progressivo impoverimento del ceto medio e una sempre maggior difficoltà nel trovare lavoro. Inoltre, se prima il passaggio tra scuola e lavoro (con la leva militare di mezzo) determinava una netta frattura tra adolescenza e mondo adulto, ora sappiamo bene non essere più così. La linea che separa l’età dello studio da quella del lavoro è spostata in avanti, la stessa laurea non garantisce un posto fisso e la precarietà lavorativa inibisce i progetti futuri. Sono cose risapute, senza fare del vittimismo, ovviamente, perché poi qualcosa si trova sempre, però è un dato di fatto che questa sia la situazione per la maggior parte dei giovani, costretti a dipendere dalla famiglia per le ristrettezza economiche.
Ma forse c’è un terzo aspetto, più profondo, che può essere scovato in quel processo di de-sacralizzazione che la cultura Occidentale ha iniziato progressivamente a vivere, diciamo, dall’inizio dell’epoca moderna e di cui oggi ne vediamo gli effetti più prossimi nell’esagerata cosificazione di tutto, persino dell’uomo.
In sintesi possiamo ammettere di assistere ad una situazione abbastanza complessa: da una parte traspare una maggiore possibilità di dialogo tra genitori e figli, il che è certamente positivo nonostante nasconda il rischio di mettere sullo stesso livello due posizioni che non dovrebbero essere tali (andava infatti recuperato il dialogo superando l’autoritarismo – che non porta ad una vera educazione ma solo all’obbedienza – ma non doveva perdersi l’autorevolezza – che invece è necessaria per il rispetto della dignità propria ed altrui). D’altra parte il mondo dei giovani e adolescenti vive una frustrante dilatazione temporale o di indeterminata transizione che impedisce loro di realizzarsi socialmente (anche per l’estrema difficoltà per i giovani di accedere a posizioni di potere a cui hanno avuto «diritto» gli allora giovani rivoluzionari degli anni Sessanta e Settanta), e questo ha fatto in modo che si creassero da soli quella realtà alternativa in cui rifugiarsi, chiudersi o passare il tempo, grazie anche alla sconfinata possibilità di evasione che propone oggi il virtuale. Un mondo forse troppo superficialmente liquidato come perdita di tempo a fronte della “vita seria”. Sarebbe da chiedersi se questa “serietà di vita” non sia essa stessa una maschera di difesa, fittizia tanto quanto il mondo virtuale perché costruita sull’effimero, una sorta di castello kafkiano, che risucchia energie e perciò stesso produce alienazione.
E se il disagio giovanile non fosse altro che la ribellione verso tale società alienante? L’incomunicabilità generazionale come reazione ad un mondo adulto a sua volta sordo alle loro legittime richieste di cura? Le nuove sfide educative potrebbero ripartire proprio da qui.